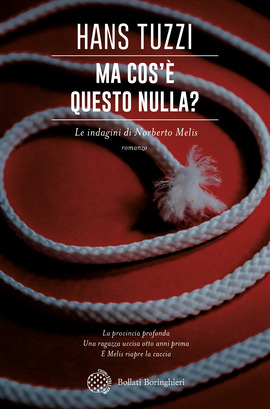Dal 25 ottobre è in libreria l’ultimo romanzo di Hans Tuzzi, Colui che è nell’ombra (Bollati Boringhieri). Abbiamo rivolto all’autore qualche domanda, non tanto sul romanzo quanto sulle sue idee e convinzioni circa scrittura e società.
Lei ha importanti estimatori, ma è sempre rimasto uno scrittore poco popolare. Perché?
Non cerco il consenso, e questo non gioca a mio favore al botteghino. Sono versatile, e mi sono misurato pure con generi “bassi” ma con scrittura non corriva: di qui la diffidenza dei lettori abituali di gialli e la preconcetta indifferenza degli accademici italiani, che, per titolo giuridico, sono ordinari, e dunque non possono capire l’extraordinario. Infine, non partecipo al grooming delle conventicole e non ho potere. Mi sembrano tutte valide ragioni per essere, come dice lei, poco popolare. Né ho difficoltà ad ammettere che la mia opera presenta una dichiarata «disappetenza al moderno», per dirla con Cesare Garboli. Questo non significa ingannarsi imbellettando il passato, anzi: chi si volta indietro si perde per sempre, come insegna il mito di Orfeo e Euridice. In una società come la nostra, dove gli “intellettuali” sono presenzialisti ridotti a poco meno che cavalli di Elberfeld, vien da rimpiangere le generose e ingenue esposizioni degli anni Cinquanta: la paura della morte atomica, e Huxley, e i concettosi e noiosissimi Sartre e Miller, convivevano con Doris Duke e Barbara Hutton che pagarono milioni di dollari per verificare con mano quanto si favoleggiava della dotazione KingSize di Porfirio Rubirosa, diplomatico della Repubblica Dominicana e unico in grado di competere in dimensioni virili con lo Scià di Persia (la sola politica estera che sembra abbia fatto scuola, sostituendo alle dotazioni anatomiche quelle missilistiche). Sì, il passato era fesso. Ma mi piace notare che l’appartamento al 45 rue de Courcelles, a Parigi, oggi residenza diplomatica della Repubblica Dominicana, fu un tempo abitato da Marcel Proust: Jupien, Charlus e Rubirosa, quel ensemble.Sì, il passato era fesso. Però non riesco ad appassionarmi a un presente idiota schwampito e infame, come ai miei occhi è il nostro. Il livello infimo della classe politica in Occidente, la Storia che non insegna nulla (sì, lo si sa ma fa sempre effetto vederlo confermato dai vari Putin, e Trump, e loro imitatori estimatori), una sfasata logica binaria che riduce a poca cosa il raziocinio delle generazioni allattate a computer, e di conseguenza la più assoluta incapacità di cercare il sapere per amore di meraviglia (quel che gli antichi greci chiamavano philosophein dia to thaumazein), tutto questo mi fa sentire sempre più estraneo verso il presente, e, il che è peggio, rancoroso per sentirmi tale.
Anche la letteratura contemporanea è investita da questa critica?
Quella di questo secol nuovo? In buona parte sì: giudicando quarant’anni fa un candidato alla pubblicazione con Einaudi, Franco Fortini parlò di «prodotti, che chiamerei non convenzionali ma convenzionati, come si dice delle cliniche che hanno rapporti privilegiati con certe mutue.» Mi sembra più che mai attuale. E Jung ha detto: «Capii che non si raggiunge nulla nella vita se non si parla con la gente solo delle cose che essa già conosce. La persona semplice non valuta appieno che specie di insulto sia parlare ai propri simili di cose che son loro ignote. Gli uomini al più tollerano un tale sconsiderato comportamento in uno scrittore, o in un poeta». Ecco, a me pare che oggi ancor più di ieri il successo arrida a chi rumina idee abbondantemente rimasticate seguendo le mode, e in particolare quelle mode che si dichiarano contro le mode, in una sempre più latrante retorica del “messaggio”, liquidata una volta per tutte da Nabokov: «Se avessi voluto mandare messaggi avrei fatto il postino». Banalità delle esposizioni, ossessiva ricerca del consenso, prosa di livello apparentemente alto ma in realtà frutto dell’omologazione delle scuole di scrittura (amo gli autori attenti allo stile, ma quale grande autore europeo fra le due guerre mondiali sentì il bisogno di cincischiare le frasi, senza peraltro dominarne senso e struttura, come fanno oggi gli autori delle più recenti generazioni? Rileggetevi Gide: «Lo stile dei Falsari non deve presentare nessun interesse alla superficie, deve essere liscio tanto da far dire a certi giocolieri: cosa ci trovate da ammirare là dentro?»), e in più maniacale attenzione al proprio ombelico… Vale qui il cortocircuito di Majakowskij: «Da quando domina il materialismo è scomparsa la materia». E, di conseguenza, è scomparsa l’ironia, e, peggio, l’autoironia: due monete, peraltro, mai circolate in Italia. Ironia nel senso greco della parola, ossia finzione; però è una finzione, come dice Vico, più vera del vero. La grande letteratura è sempre ironica perché non spiattella convinzioni, non dispensa ovvie verità. Bisogna passare attraverso la finzione per dire la verità, non è un paradosso: il saggio sa che bisogna rinunciare per possedere, lo sportivo sa che si deve arretrare per saltare meglio, e lo scrittore dovrebbe sapere che bisogna sottintendere per affermare. Orfeo perde Euridice per il troppo umano bisogno di assicurarsi invece di fidarsi senza guardare, ma Gesù ricorda agli uomini che «chi ama la propria vita la perderà». Da ateo, l’ho sempre trovata una sublime lezione di umanità. E di scrittura. Già, perché, come ha detto un sommo, «scrivere è dare il cuore a qualcosa di più profondo».
Un esempio concreto di sottinteso?
Due, per capirci meglio. E visto che ho appena citato Proust, con lui riprendo, che in una lettera scrive: «Prima che l’ultimo urlo si sia spento si precipitano in bagno e tutto termina con un rumore d’acqua. La mancanza di transizione mi stanca per loro, perché, se c’è una cosa che detesto dopo, subito dopo, è muovermi. Per quanto egoismo ci sia nel trattenere nello stesso posto il tepore di una bocca che non ha più nulla da ricevere.» Si tratta, ripeto, di privata corrispondenza. Ma quanto stile in quel trattenere il tepore di una bocca che non ha più nulla da ricevere. E se ne fa buona scolara, tale da superare forse il maestro, Anna Maria Ortese quando scrive Il porto di Toledo: «Risentivo di nuovo il suo bacio sopra la gamba, dove la calza finiva e cominciava un po’ il mio essere»: quel dove cominciava il mio essere è magistrale e ardente evocazione erotica. Tanto alto, là dove non dice, si fa ogni parlare d’amore. Tanto alta, nella reticenza, è ogni pagina di vera letteratura. Ma nella società contemporanea, mossa da appetiti e priva di desideri, la naturale conseguenza è che gli intellettuali assolvano il loro ruolo etico dandosi alla pubblica esibizione in forme magniloquenti e urlate, mentre invece l’etica, nell’arte come nella società, matura da gesti intrapresi senza pubblico, in austero anonimato.
Ma quali sono, per lei, altre componenti essenziali della grande arte? O almeno una fra esse?
Cercherò di dirlo con un esempio. Per i capelli del Cristo alla colonna Antonello da Messina usa il cinabro velandolo poi con ocra: un colore che al tempo costava sessanta volte più dell’altro viene usato sotto, coperto in gran parte dal colore più economico. L’effetto è tuttavia stupefacente. Questa è grande arte, l’altra soluzione sarebbe facile risultato per pubblico di facile contentatura. La grande arte non è mai facile: può sembrare semplice – e non lo è – ma facile mai. Ciò vale, naturalmente, anche per la letteratura. Che un capolavoro come il Don Chisciotte, capace, in alcune sue parti, di annoiare volutamente il lettore per rimanere fedele alla forma data all’idea, sia stato, da subito, un best-seller, è l’eccezione, non la regola.
Da sua estimatrice, mi chiesi cosa mai avrebbe potuto ancora scrivere dopo quell’assoluto che è Nessuno rivede Itaca, e invece lei ha fatto due mosse imprevedibili, con due romanzi come Curiosissimi fatti di cronaca criminale, dove si entra e esce da mondi paralleli, e questo, Colui che è nell’ombra, del quale volutamente non intendo anticipare nulla ai lettori perché è un sortilegio ugualmente riuscito. Una bella prova di muta, direi, per usare un termine della biologia, scienza a lei cara come dimostrano le divagazioni sulla psichedelica percezione dei colori del paguro in Vanagloria o sul multiplo pene delle lucertole in Nessuno rivede Itaca.
Già, Nessuno rivede Itaca: finitolo, io sono morto e rinato. Allora, una volta per tutte, presi piena e profonda coscienza dei mutamenti perenni del mondo, di come terre credute ferme tali non siano, e d’improvviso scompaiano. Il mio segno zodiacale è lo Scorpione e gli junghiani considerano la caratteriologia scorpionica capace di smuovere energie al servizio della trasformazione quintessenziale. Gli alchimisti associavano questo simbolo all’abbandonarsi e diventare, e chiamavano “tempo dello scorpione” il momento in cui i metalli di base si trasformavano in oro. E l’antico Egitto, lo vogliamo tacere? La dea scorpione Selket rappresentava la capacità di sopravvivere alle transizioni più radicali. Morte e rinascita, trasformazione… Del resto, non siamo mai “uno”; come mi scrisse un amico, a proposito dei miei romanzi, la nostra anima è abitata dai molti che siamo stati e che vorremmo essere. «Nasciamo già in Tanti e aspiriamo all’Uno», mi scrisse. Dietro ogni pensiero alchemico si cela questa drammatica utopia. «Forse dovremmo rinunziarvi e instaurare rapporti di buon vicinato con Tutti, accettando di essere consapevolmente abitati ora da Questo ora da Quello e poi da quell’Altro ancora… Valenti aurighi, in quest’arte dovremmo esercitarci, e a questa tendere, finché ci sarà possibile.» Purtroppo, merita invece ricordare una riflessione di Jung: «La totalità di una nazione non reagisce mai come un normale individuo moderno, ma sempre come un gruppo primitivo. Crimini, che l’individuo da solo non potrebbe mai avere la forza di reggere, vengono perpetrati senza alcun ritegno dal gruppo. No, i demoni non saranno affatto banditi. Ogni uomo che smarrisce la sua ombra, ogni nazione che si sente moralmente superiore, è la loro preda». Senz’ombra, senz’anima, dice il proverbio tedesco che ispirò von Chamisso. Il che ci porta dal Piccolo al Grande Mondo, e viceversa. E alle considerazioni su passato e presente con le quali s’è aperta questa chiacchierata.
Uno scrittore dovrebbe essere nel presente, non trova?
Nel presente, ma non del presente. Balzac era nel presente, altroché se lo era, ma le sue trame si svolgono tutte un quarto di secolo prima della pubblicazione. Complice l’età, aumenta il mio rifiuto della compiacenza, e del presente, troppo affollato di esseri umani, vedo più i difetti che i pregi…
La grande villa del romanzo trasformata in resort, ad esempio, con la nuova fauna umana?
Ad esempio, sì. Purtroppo ciascuno di noi tende a fissarsi sugli anni migliori della propria vita, e per me furono i Sessanta, così come per mia nonna furono i Venti (la generazione dei miei genitori a vent’anni si trovò in guerra, invece: ma paradossalmente l’uomo prova un terribile amore per la guerra, e molti di quei reduci, io bambino, con il ricordo andavano alle esperienze, talvolta atroci, di quegli anni). Del presente in realtà poco mi sfugge, ma lo guardo da un punto di vista se non prevenuto, certamente estraneo: ne colgo, avendo coltivato altri modelli, più la volgarità che le potenzialità. E mi sento incapace di tenere il passo – disumano – della rivoluzione tecnologica. So ancora cogliere il sale della vita ma, come dice l’Evangelista, «se il sale perde il suo sapore, con che cosa lo si renderà salato?».
E allora, chiuda con un aforisma.
La proprietà di linguaggio non è proprietà privata. E il rispetto di sé stessi è anche rispetto dei lettori di qualità.
********************************
Hans Tuzzi, Colui che è nell’ombra, Bollati Boringhieri, pagine 176 euro 16,00
Nucci intervista Tuzzi su IlLibraio
Sul precedente romanzo, Curiosissimi fatti di cronaca criminale, segnaliamo questa intervista