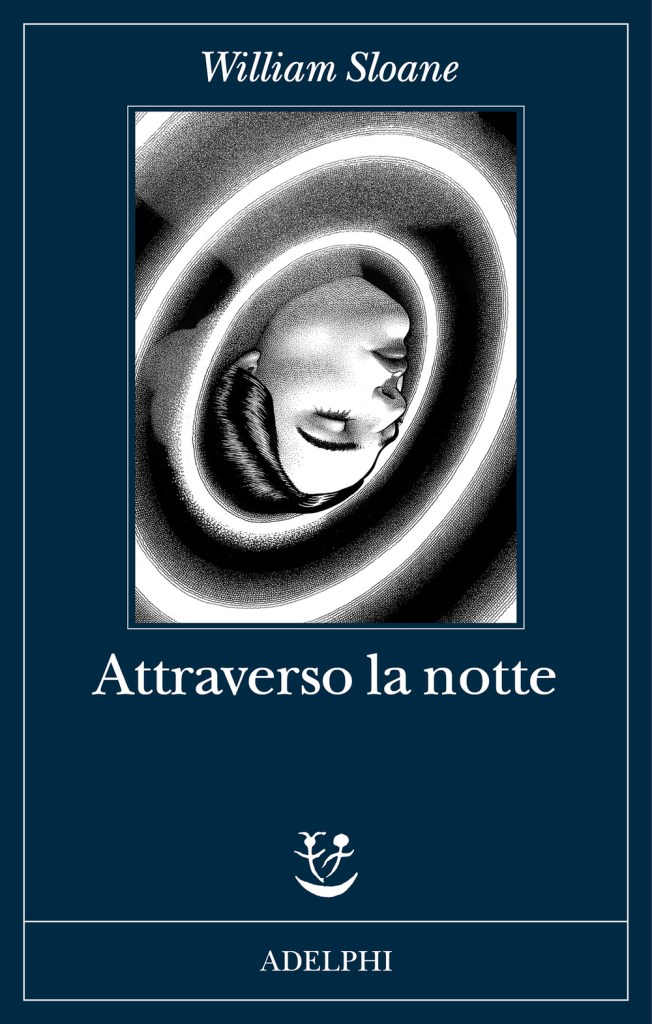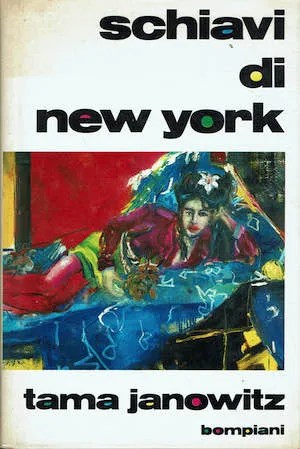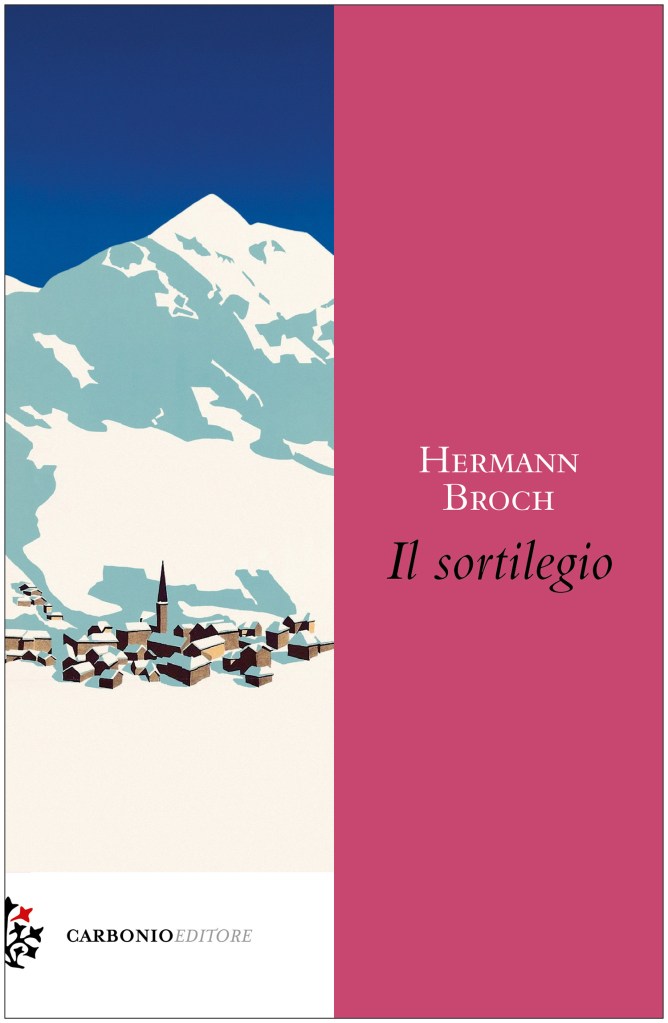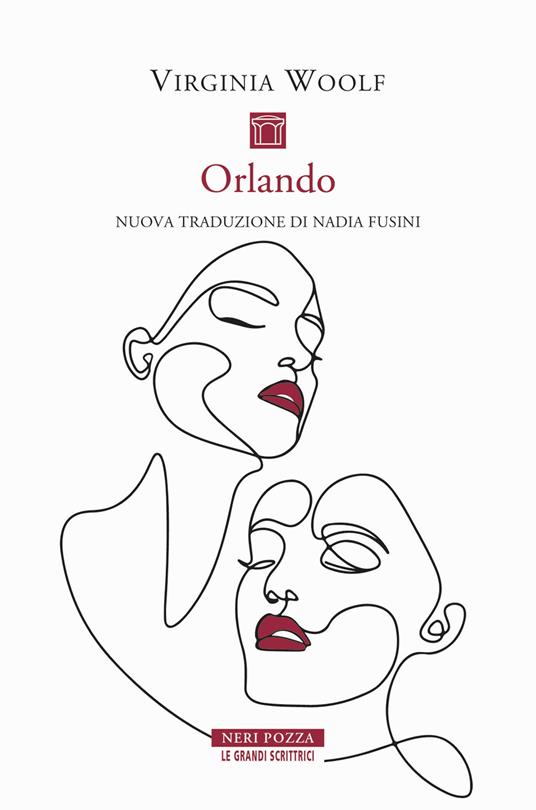Questo romanzo irriverente e corrosivo mette in scena un episodio dell’insurrezione di Dublino del 1916: l’occupazione armata di un ufficio postale da parte di un gruppetto di sette individui guidati da un capo assai bizzarro, Jack Mac Cormack. Gli uomini dell’esiguo drappello resistono all’assedio dell’esercito inglese, ma cadono uno dopo l’altro nelle seducenti trappole della giovane Gertie Girdle, rimasta chiusa in bagno durante l’assalto. Uscito per la prima volta nel 1947, e attribuito dal suo autore alla fittizia scrittrice irlandese Sally Mara, Troppo buoni con le donne è una specialissima storia in cui ritmo, invenzione, senso del dialogo vengono trasposti in un racconto poliziesco dominato da forza narrativa e humour.(dal Catalogo Einaudi)
Traduzione di Giuseppe Guglielmi
Prefazione a cura di Carlo Boccadoro
Un viaggio in ottovolante dal ritmo indiavolato che corrode con il paradosso e il divertimento tutti i luoghi comuni letterari che riesce a trovare sul proprio cammino.(dalla prefazione di Carlo Boccadoro)
Titolo originale On est toujours trop bon avec les femmes era liberamente ispirato alla Rivolta di Pasqua, come fu indicata l’insurrezione armata scoppiata a Dublino nel 1916, guidata dagli Indipendentisti dell’esercito per ottenere l’autonomia dal Regno Unito, sette dei quali occupano la stazione postale di Eden Quay difendendola anche con esecuzioni brutali, ma in questo contesto tra resistenza ed eroismo, si inserisce un elemento inatteso: la giovane impiegata, Gertie Girdle, durante l’assalto era chiusa in bagno a studiare… il gorgogliare degli sciacquoni.
La prima edizione del 1947 vedeva come autrice Sally Mara, un’irlandese sconosciuta, pseudonimo dietro il quale si celava infatti Raymond Queneau.
Pubblicato lo stesso anno di “Esercizi di stile”, sicuramente la più conosciuta e apprezzata opera di Queneau. raccontare in novantanove modi diversi un breve episodio, in sé banale, mutandone caleidoscopicamente lo stile in tutta una serie di varianti con effetti a dir poco pirotecnici, “Troppo buoni con le donne” è un’operazione letteraria che sa trasformare una storia drammatica in un romanzo dalle caratteristiche opposte, così come il più famoso “Esercizi di stile” racconta un banale episodio della vita quotidiana con novantanove variazioni sullo stesso tema e, appunto, con stili diversi..
Raymond Queneau nasce il 21 febbraio 1903 a Le Havre. Si laurea in filosofia e aderisce al movimento surrealista, dal quale si distaccherà nel 1929. Nel 1928 sposa Janine Kahn, sorella della moglie di Breton. Nel 1933 esce il suo primo romanzo, La gramigna, che ottiene un immediato successo di critica e di pubblico. Dal 1932 al 1939 segue, all’École Pratique des Hautes Études, i corsi di Kojève e di Koyré su Hegel e quelli di Puech sulla gnosi e sul manicheismo. Nel 1941 diventa segretario generale delle edizioni Gallimard. Dal 1947 al 1952 collabora a «Les Temps Modernes». Nel marzo del 1952 è eletto all’Académie Goncourt. Nel 1954 accetta di dirigere l’«Encyclopédie de la Pléiade». Nel settembre 1960 gli viene dedicato il seminario di Cerisy-la-Salle, e in quell’occasione fonda, insieme a François Le Lionnais, l’Oulipo. Tra i suoi libri ricordiamo: Figli del limo (1938), Un rude inverno (1939), Pierrot amico mio (1942), Suburbio e fuga (1944), Esercizi di stile (1947 e 1969), Troppo buoni con le donne (1947 e 1971) Piccola cosmogonia portatile (1950), La domenica della vita (1952), Zazie nel metró (1959), I fiori blu (1965), Icaro involato (1968), tutti pubblicati in Italia da Einaudi. Muore a Parigi il 25 ottobre 1976.(da Einaudi Autori)