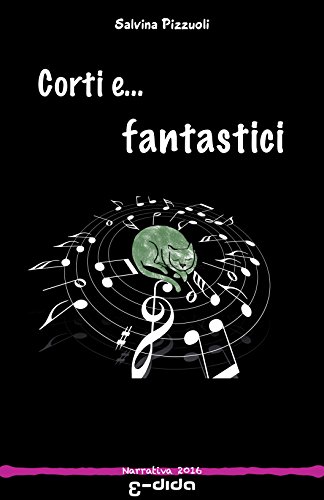Maurizio e i quattro cammelli

Non amo andare in spiagge affollate, non amo trasportare in nome di una comodità successiva, lettini e sedie reclinabili, teli da bagno, ombrelloni leggerissimi, ma voluminosi e ingombranti. Amo andare in spiaggia con il minimo indispensabile: un cappello, un paio di occhiali, un telo per stendersi e asciugarsi al sole, una crema, un libro. Non dovrei pertanto andare in spiaggia con Daniela che in questo è il mio perfetto contrario. Tanto più io amo appartarmi, alleggerirmi di pesi inutili, tanto lei ama gli incontri, gli inutili ammennicoli di una comodità più pensata che vissuta proprio perché non sta un minuto a sedere sulla sua rossa sedia superleggera o sdraiata sul suo lettino o all’ombra del suo ombrellone che non può fregiarsi del merito di averle mai potuto offrire un gradito refrigerio, nemmeno sotto il dardeggiare del solleone.
In comune abbiamo solo l’amore per la spiaggia libera, dove ciascuno può scegliere l’angolazione, la posizione e la visuale che più gli aggrada. Anche in questo comunque differiamo un poco perché, scelta la spiaggia, lei piazza ombrellone, sedie e lettino sempre nello stesso punto in modo da intavolare quelli che ama definire rapporti umani.
È arrivata qualche giorno prima di me, ma conosce già tutti habituè e occasionali; non dimentica infatti mai una faccia e già al secondo incontro li saluta festosa come li conoscesse dall’infanzia. Sotto certi aspetti ha un bel carattere aperto e godereccio che spesso invidio poiché preferisco starmene rintanata nella mia ostinata musoneria. Con Daniela non mi è possibile e, come spesso dice ridendo affettuosa, sono costretta a uscire dalla pelliccia d’orso nella quale vivo inverno ed estate. Quest’anno siamo tornate esattamente nella stessa spiaggia dello scorso anno dove Daniela ha trascorso tutto il periodo delle sue vacanze mentre io le ho fatto compagnia tra un week end e l’altro; sono un’inquieta oltre che un’orsacchiotta, nomignolo con cui bonariamente ama canzonarmi, e non posso fermarmi a lungo in uno stesso posto; Daniela al contrario cerca le rimpatriate e i soggiorni prolungati perché ha bisogno di acclimatarsi, di sentirsi come a casa, circondata da volti e parole amichevoli.
Negli anni ho capito meglio la funzione che assolve in realtà il suo ombrellone: è un crocevia, è un punto di incontro, di passaggio, di sosta con chiacchierata o di pausa con e senza invito. Da qui infatti passano tutti quelli che transitano sulla spiaggia senza distinzione di età, colore, abitudini, passioni, idee e ideali perché, come sostiene Daniela e, non lo dice solo come battuta, da tutti lei ha sempre imparato qualcosa e a tutti deve molto. Non credo esista un esempio di tolleranza praticata come quella di Daniela.
Mi sono trovata così a sostenere una incredibile conversazione con una signora tedesca che parlava solo il tedesco inframmezzandolo con parole in inglese, francese e italiano, ma con la quale Daniela è riuscita a intrattenersi per un’ora. Non ho mai osato chiederle di cosa avessero parlato e se si era trattato di un vero dialogo o di un vaniloquio visto che Daniela non ha alcuna predisposizione per le lingue e ignora completamente il tedesco, non conosce il francese e intende poco l’inglese. So solo che verso mezzogiorno la signora tedesca ci ha salutate e che il commento di Daniela è stato: – simpatica, vero?!
Subito dopo è passato a salutare Yoshi, indiano di Calcutta, così si faceva chiamare; l’ombrellone di Daniela rappresenta per lui la sosta per una meritata sigaretta. Si è seduto, lui all’ombra gradita, lei tra il lettino e la sedia che ora fungono da appoggio per le bacheche ambulanti di Yoshi colme di collane, bracciali, anelli indiani. Sotto l’ombrellone di Daniela ha fatto i migliori affari conoscendo Daniela i problemi di Yoschi e spingendo i tutti che conosce a risolverglieli, almeno quelli economici.
Dopo Yoshi c’è stata una pausa; la spiaggia si è svuotata e siamo rimasti in pochi. Vista a quest’ora cambia aspetto: gli ombrelloni, non più fitti, punteggiano la sabbia come puntine su una tavolozza di compensato e con i loro allegri colori la vivacizzano nella sua coloritura uniforme e giallastra; i piccoli non riempiono con strilli eccitati lo spazio intorno a noi, ma raccolti dalle madri, come la chioccia con i pulcini, sostano sotto gli ombrelloni mordicchiando panini ripieni che troneggiano enormi e tremolanti nelle loro piccole mani. Il passeggio lungo la battigia è completamente cessato, sostituito da pigre sedute, tra lo sciabordio delle onde, di accaldati bagnanti; più in disparte, incurante del sole, c’è Claudio, dedito ad una delle sue creazioni. Daniela sa tutto di lui e spesso lo incoraggia a proseguire nella confezione delle sue piccole produzioni. A Claudio piace soprattutto trasformare ciò che la natura gli offre e dalle sue mani laboriose nascono capolavori di cesello. Di primo mattino è già sulla spiaggia alla ricerca di sassi, conchiglie e pietre pomici; raccoglie solo ciò in cui intravede già l’aspetto nuovo, quasi lo scoprisse nascosto tra le pieghe della materia. È un demiurgo dei piccoli oggetti: quando ha trovato quello che lo conquista non si stacca dal suo lavoro fino a compimento. Il mio sguardo si sposta ora da Claudio curvo sul suo lavoro e corre leggero e si sofferma pigro su questo paesaggio d’agosto godendo una pausa tra visitatore e visitatore. Daniela non c’è; si muove da ombrellone a ombrellone come le pedine di una dama o si accoccola accanto ai bagnanti sulla battigia o sbircia incuriosita le mosse di Claudio.
Sto quasi per appisolarmi quando con voce alta e concitata Daniela annuncia: – Maurizio, c’è Maurizio!
A mala pena distinguo nella direzione in cui si è girata un puntino bianco affiancato da un ammasso più scuro, le due cose procedono sulla sabbia lentamente, quasi a fatica, sostenendosi a vicenda: ora il bianco pende verso la massa scura, ora la massa scura si inclina verso il puntino bianco.
Delineandosi meglio sull’orizzonte vuoto riesco finalmente a intravedere e distinguere un uomo e un borsone e Daniela che gli corre incontro sbracciandosi.
Si dirigono ora verso di me o forse è meglio dire verso l’ombrellone, lei sempre più accalorata, lui sempre più curvo.
-Ti presento Maurizio – è la voce eccitata di Daniela – è marocchino, di Fez.
-No – la corregge lui – di un villaggio vicino.
Maurizio non è il suo vero nome; come molti ha preferito integrarsi nella nostra realtà almeno con il nome che si è scelto arrivando.
Non so quanti anni possa avere; comunque non più di quaranta. La sua faccia non è bella, ma gli occhi sono intensi e il sorriso è aperto e accattivante.
Sta raccontando a Daniela del suo nuovo bambino; ogni volta che ritorna dall’ Italia in Marocco, la sua famiglia cresce di un’unità. Ride alla battuta scontata di Daniela e risponde, abbassando la testa, che dovrà lavorare ancora di più.
-È giovane sai – sta dicendo intanto Daniela rivolta verso di me – e ha già cinque figli e una moglie da mantenere; una sola perché non potrebbe mantenerne di più!
Maurizio ride di nuovo alla battuta e mi guarda, poi abbassa gli occhi e mi guarda ancora.
Mi sento in imbarazzo e mi chiedo se c’è oppure se ho qualcosa di strano per essere guardata con tanta insistenza.
Come al solito è Daniela a trarmi d’impaccio; capisco infatti dal suo atteggiamento che il suo intervento ha a che vedere con la guardata di Maurizio.
-Le bionde hanno per Maurizio un fascino particolare, normale, non ti pare?
-Se avessi quattro cammelli – sta intanto dicendo Maurizio, quasi parlando a voce alta e inseguendo il filo dei propri pensieri – sarei un uomo ricco, non dovrei spostarmi dal mio paese e potrei avere anche due mogli, una bionda, volendo!
Mi guarda e ride; una risata bella, spensierata, contenta. Contagia anche me e Daniela che, rivolta a Maurizio, esordisce dicendo -Questa battuta è troppo spassosa, la voglio proprio raccontare!
-Anch’io – risponde Maurizio con arguzia, – la voglio proprio raccontare – e ripreso il suo pesante saccone si avvia a passo lento verso nuovi e potenziali clienti.
Maurizio non si è ancora del tutto allontanato dall’ombrellone, ma già Daniela ha rivolto la sua attenzione altrove e, guardandomi con occhio indagatore, mi chiede: – E Claudio? (da Corti e fantastici, Edida)